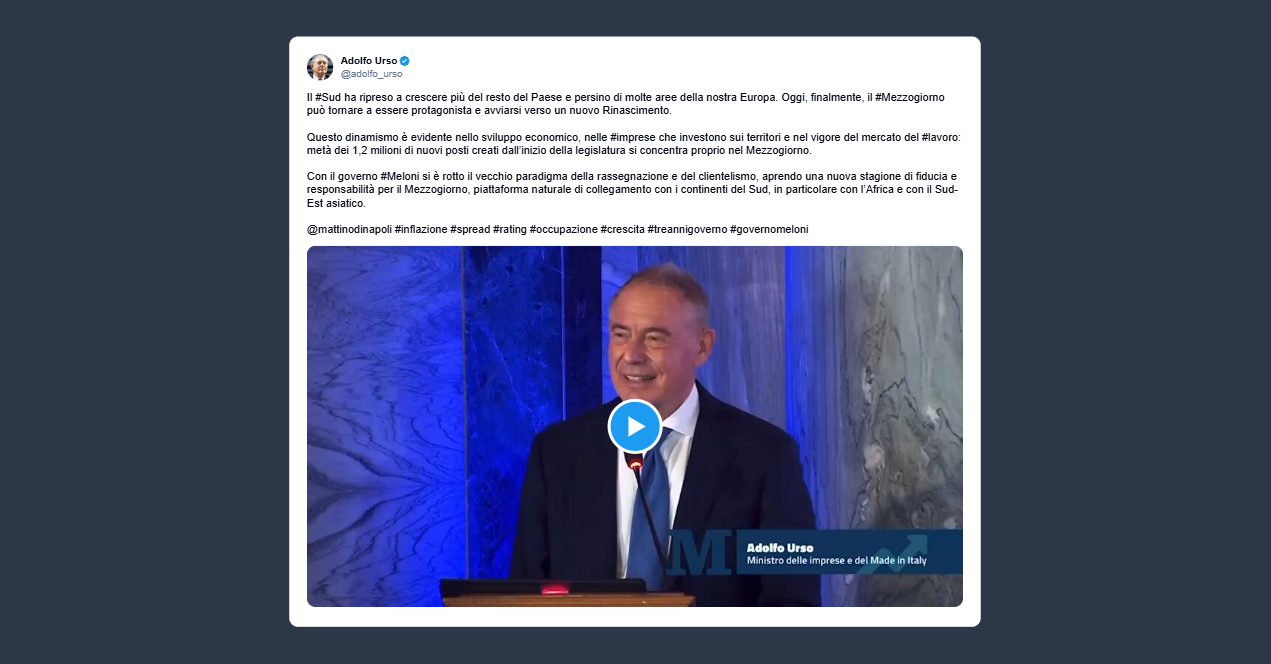Ore 22,17 del 17 ottobre. Campo Ascolano, comune alle porte di Roma. Nella notte, all’improvviso, si sente un boato. Tremano i vetri delle case. Un ordigno con circa un chilo di esplosivo fa saltare in aria l’auto di un noto giornalista d’inchiesta e quella di sua figlia, passata di lì solo qualche minuto prima. Si tratta di un attentato, ma non siamo negli Anni di Piombo. È il 2025, e l’attacco ai danni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, riporta al centro della discussione pubblica il tema della libertà di stampa.
Secondo l’annuale classifica mondiale dei Paesi in cui l’attività giornalistica è sottoposta a limitazioni o censure, stilata da Reporter Senza Frontiere, nel 2025 l’Italia si posiziona al 49esimo posto, scendendo di tre gradini rispetto ai dati del 2024: il risultato peggiore in Europa Occidentale. In particolare, la libertà dei giornalisti italiani «continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, soprattutto nel sud del Paese, nonché da diversi piccoli gruppi estremisti violenti», si legge nel rapporto.
Ma qual è la metodologia alla base dell’indice che fotografa lo stato della libera informazione in 180 nazioni del mondo? Rsf spiega che ogni Paese riceve un punteggio da 0 a 100 – dove 100 rappresenta la piena libertà di stampa – calcolato su dati quantitativi relativi agli abusi subiti dai giornalisti, ma anche attraverso una valutazione qualitativa fondata su un questionario compilato da esperti del settore. Il valore finale deriva da cinque indicatori di pari peso: contesto politico, quadro legale, contesto economico, contesto socioculturale e sicurezza. Reporter senza frontiere raccoglie poi i risultati in una mappa mondiale, colorando in verde i Paesi con una situazione “buona”, per arrivare al rosso scuro, che segnala condizioni “molto gravi”. L’indice si riferisce all’anno precedente, ma può essere aggiornato se avvengono eventi significativi come guerre, colpi di Stato o nuove restrizioni alla stampa.
Negli anni, l’indice sulla libertà di stampa ha ricevuto diverse critiche per la sua componente soggettiva. I detrattori sostengono che i questionari compilati da giornalisti o esperti del settore possano restituire risposte influenzate dal contesto culturale e professionale di provenienza, rendendo più difficile il confronto tra Paesi. Inoltre, accademici e analisti osservano che le decisioni su quali indicatori includere e come pesarli influenzano fortemente il risultato finale e possono produrre classifiche che sembrano “semplificare” realtà complesse. C’è poi da considerare la crescente difficoltà nel monitoraggio della libertà di stampa nel mondo digitale. Disinformazione, panorama legislativo delle piattaforme social e la diffusione di sistemi di Intelligenza artificiale rendono sempre più complessa la misurazione.
I reporter italiani «denunciano anche i tentativi dei politici di ostacolare la loro libertà di occuparsi di casi giudiziari attraverso una ‘legge bavaglio’, che si aggiunge alle procedure Slapp, una prassi comune in Italia», sottolinea inoltre il documento di Rfs.
Le Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation) – che tecnicamente rientrano nella categoria delle “liti temerarie” – sono azioni legali intentate non in buona fede per vincere una controversia legittima, ma per intimidire, zittire o punire chiunque cerchi di partecipare o esprimersi su questioni di interesse pubblico. I soggetti più spesso presi di mira sono i media, le Ong o i rappresentanti della società civile. I “mandanti”, invece, sono solitamente potenti gruppi aziendali o portatori di interessi determinati a dissuadere il lavoro di inchiesta di giornalisti o organizzazioni. La strategia è quella di presentare querele per diffamazione, che – considerando l’anatomia della Giustizia italiana – sono di solito lunghe e sempre molto costose. Al punto che, talvolta, la semplice minaccia di un’azione legale è sufficiente a raggiungere lo scopo desiderato. E così cessano le indagini, gli articoli scompaiono dallo “sfoglio” dei giornali e i rapporti delle Ong non vedono la luce.
Gli ultimi dati ufficiali del Parlamento europeo prendono in esame il periodo tra il primo gennaio 2022 e il 31 agosto 2023, nel quale vengono segnalate 47 querele intimidatorie nei Paesi membri dell’Ue. L’Italia ha registrato il 25,5% di questi casi (12 processi in tribunale). Il report, tuttavia, specifica che si tratta di un campione rappresentativo scelto per analizzare schemi ricorrenti, e non di un vero e proprio “censimento” di tutti i casi di Slapp verificatisi in Europa.
A fornire un quadro più ampio è il “Case” (Coalition Against Slapps in Europe), un gruppo di oltre 110 organizzazioni non governative europee. Secondo l’ultimo report dello scorso anno, l’Europa conta 166 Slapp nel 2023, mentre l’Italia risulta tra i Paesi Ue con il maggior numero di casi (26), seguita da Romania (15), Serbia (10) e Turchia (10).
Un caso a lungo discusso – e bollato dall’European Centre for Press and Media Freedom come episodio di Slapp – è quello della querela per diffamazione presentata da Giorgia Meloni contro Roberto Saviano. Il fatto risale al 2020, quando lo scrittore, ospite al programma di La7 “Piazza Pulita”, aveva definito la leader di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini «bastardi» nell’ambito di una discussione sul tema dei migranti e sulla gestione dei porti italiani. Gli avvocati della Meloni avevano chiesto un risarcimento di 75mila euro ma, dopo tre anni, il processo si è concluso per Saviano con una condanna al pagamento di una multa di mille euro (con sospensione condizionale della pena).
Un altro esempio significativo è quello di Federica Angeli, giornalista di Repubblica che vive sotto scorta per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Angeli è stata bersaglio, nel corso della sua carriera, del numero record di oltre 100 querele per diffamazione, come riporta la Federazione Nazionale Stampa Italiana.
E poi c’è appunto Ranucci che, insieme ai colleghi della redazione di Report, conta innumerevoli querele e minacce a proprio carico. Sull’attentato al giornalista Rai, il segretario della Presidenza del Senato, Marco Lombardo, ha scritto su X: «non basta condannare l’atto criminale, confidare nelle indagini della magistratura e manifestare la solidarietà, dobbiamo assumerci la responsabilità politica. Cosa intendiamo fare per invertire questo clima di delegittimazione verso il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione? Vogliamo approvare finalmente anche in Italia la legge anti Slapp contro le querele temerarie nella prossima legge di delegazione europea?».
L’Unione Europea ha approvato nell’aprile 2024 la Direttiva Ue 2024/1069, nota come legge anti-Slapp “Daphne” in memoria della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. La direttiva stabilisce meccanismi di archiviazione immediata dei procedimenti infondati, risarcimento dei danni per le vittime e sanzioni dissuasive per gli autori di queste liti temerarie.
Gli Stati membri hanno tempo fino a maggio 2026 per recepirla, ma l’Italia non ha ancora avviato l’iter formale di recepimento, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’Ordine dei Giornalisti, della Fnsi e di varie associazioni per la libertà di stampa.
La storia del giornalismo insegna che in passato troppo spesso le minacce ai reporter si sono trasformate in vere e proprie esecuzioni. Mauro De Mauro, Mino Pecorelli, Peppino Impastato, Pippo Fava, Giancarlo Siani. Sono solo alcuni nomi dei tanti, troppi giornalisti uccisi. Il loro sacrificio deve ricordare non solo ai professionisti del settore, ma a tutta la società civile, l’importanza di tutelare uno dei principi fondamentali di ogni Paese che possa realmente definirsi democratico: la libertà d’informazione.