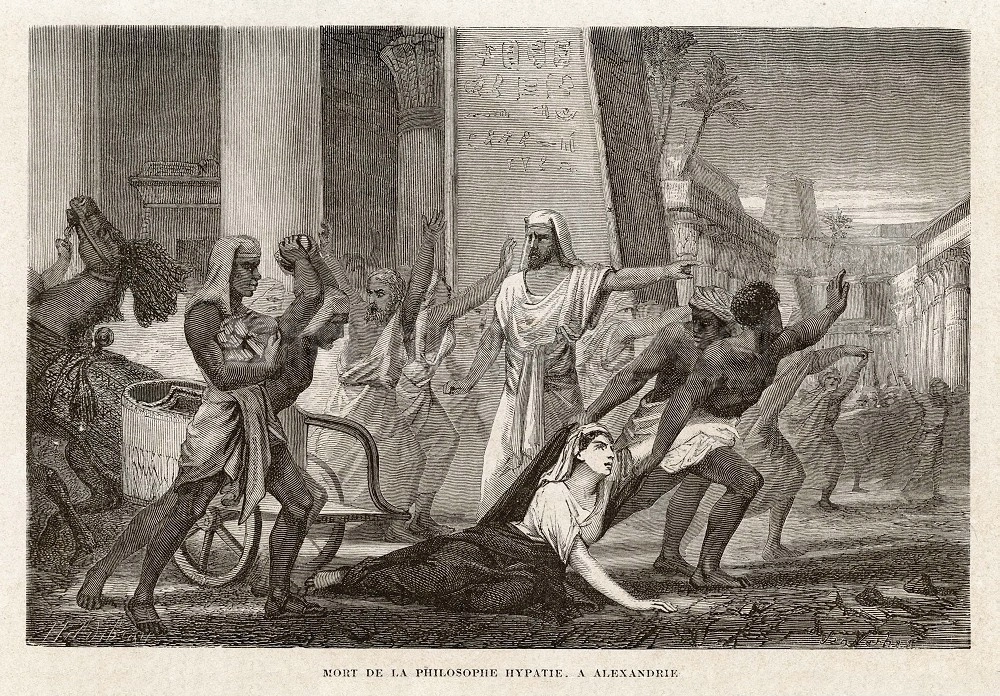Il pittore fiorentino del XVI secolo Jacopo da Pontormo (1494-1557) fu uno dei principali esponenti del movimento manierista. Questo stile artistico, emerso tra l’Alto Rinascimento e il Barocco, si ispirava alle opere degli ultimi anni di Michelangelo e Raffaello. Apprezzato dai sovrani italiani e dagli intellettuali di corte, il manierismo si diffuse in seguito in tutta Europa.
Il termine “maniera” era sinonimo di stile – lo stile predominante dell’epoca – e gli artisti manieristi sperimentarono nuovi linguaggi rielaborando le rappresentazioni naturalistiche e armoniose del Rinascimento. Prediligevano uno spazio pittorico stilizzato e figure idealizzate, e utilizzavano colori vivaci e insoliti in composizioni eleganti e sofisticate.

Pontormo si dedicò principalmente alla pittura religiosa, realizzò affreschi, disegni e ritratti. Queste opere riflettono la capacità distintiva di Pontormo di suggerire con sensibilità la psicologia interiore del soggetto, presentandone al contempo l’immagine pubblica raffinata.
Jacopo Carucci nacque a Pontorme, oggi quartiere di Empoli. Fu apprendista di Leonardo da Vinci e Andrea del Sarto, ma oltre all’influenza dei due maestri, si formò anche alla scuola di Michelangelo e degli artisti europei del Rinascimento, in particolare di Albrecht Dürer. Sebbene l’estetica innovativa di Pontormo si sia evoluta nel corso della sua carriera, gli elementi stilistici fondamentali sono presenti in tutta la sua opera. Come spiega il Getty Center nella biografia dell’artista, questi erano «l’energia psichica sopra la fisicità, i ritmi lineari armoniosi, il movimento inquieto, lo spazio ambiguo [e] i colori vivaci. Per Pontormo, l’opera d’arte era un ornamento».
Giuseppe con Giacobbe in Egitto, conservato alla National Gallery di Londra, è un dipinto sorprendente i cui colori mostrano una «pallida iridescenza ultraterrena» che richiamano gli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo.
Oltre all’allusione al maestro, quest’opera riflette la continuità del lignaggio artistico. Si ritiene che raffiguri Agnolo Bronzino, allievo dello stesso Pontormo, diventato anch’egli un famoso pittore manierista. Il giovane Bronzino, seduto in primo piano sul gradino più basso del palazzo del Faraone, indossa un cappello nero e tiene un braccio sopra un cesto.

L’immagine è un esempio di narrazione continua, creata da diverse sequenze di una storia racchiuse in un’unica composizione, quattro episodi tratti dalla storia di Giuseppe nell’Antico Testamento: a sinistra, Giuseppe presenta il padre Giacobbe al Faraone; Giuseppe, in basso a destra, seduto su un carro mentre ascolta le vittime della carestia; Giuseppe sale le scale con i figli per visitare il padre morente e infine Giacobbe, in alto a destra, che benedice i nipoti. Questo dipinto esemplifica l’abilità artistica unica e la vivida immaginazione di Pontormo.

L’ALABARDIERE
Il Ritratto di un alabardiere (forse Francesco Guardi) ha una provenienza illustre che annovera una nota famiglia fiorentina, un cardinale francese, una principessa Bonaparte e una dinastia bancaria americana.
Il dipinto, messo all’asta nel 1989, è stato aggiudicato al Getty per l’incredibile cifra di oltre trentacinque milioni di dollari, un record per il dipinto di un maestro del passato. Al momento dell’asta, si riteneva che il dipinto ritraesse il duca Cosimo I de’ Medici, membro della potente famiglia fiorentina e storico governatore della città. Grandi intenditori d’arte, i Medici erano mecenati di Pontormo, ma l’identificazione più accreditata del soggetto è quella di Francesco Guardi, di cui si sa poco.

Il giovane uomo elegante è in piedi davanti a una fortificazione muraria di un verde indefinito e impugna un’alabarda, un’arma composta da un’ascia da battaglia e una picca montata su un lungo manico. La superficie ruvida dell’arma contrasta con gli abiti raffinati del soldato, che sul berretto rosso sfoggia uno stemma ovale alla moda con incisa un’immagine del mitologico gigante Anteo sconfitto da Ercole.
Pontormo ritrae l’alabardiere come un giovane eroico idealizzato, con guance rosee e un fisico agile. Nonostante l’inesperienza militare data la giovane età, il soldato ostenta sicurezza, guardando con freddezza lo spettatore col braccio sui fianchi. Ma con grande sensibilità, l’artista riesce a trasmette anche la vulnerabilità del personaggio.
Nella Galleria degli Uffizi di Firenze è conservato un raffinato studio a gessetto rosso del dipinto realizzato dal Pontormo. A differenza dell’opera finale, il disegno mostra l’alabardiere in una posizione più frontale.
L’artista dipinse un altro famoso ritratto di un giovane militante repubblicano al tempo dell’assedio di Firenze, Ritratto di giovane con berretto rosso (Carlo Neroni?), che risale al 1530 circa. Per oltre duecento anni si è creduto che il dipinto originale fosse andato perduto. Gli specialisti conoscevano quest’opera solo attraverso documenti e incisioni. Nel 2008 è stato ritrovato nella collezione privata dell’aristocratico britannico Nicholas Alexander, conte di Caledon.
L’opera ha subito diverse traversie e passaggi di proprietà, tanto che ancora oggi lo status del dipinto rimane incerto. Un accordo di esportazione temporanea ha comunque permesso l’esposizione del dipinto, recentemente restaurato, in mostre a Firenze, New York e Los Angeles.

Come nel caso di Francesco Guardi, poco si sa della vita del diciannovenne combattente repubblicano volontario Carlo Neroni, si notano comunque somiglianze stilistiche tra i due dipinti: entrambi gli uomini sono raffigurati come giovani alteri aristocratici in posizione leggermente di traverso, con una mano sul fianco e un cappello rosso.
La National Gallery ha commentato con ammirazione: «Realizzato su un audace disegno a mano libera, Ritratto di un giovane con berretto rosso trasmette il carattere e gli ideali del soggetto attraverso la composizione, la posa e la padronanza della tecnica pittorica. Le pennellate sono applicate con movimenti rapidi ed energici».
Mentre nel ritratto precedente un soldato tiene un’alabarda, questo mostra un giovane affascinante con in mano una misteriosa lettera, e viene da chiedersi se voglia attirare l’attenzione sulla corrispondenza o se stia cercando di nasconderla. Forse si tratta di una lettera d’amore e, come l’anello che porta all’altra mano, potrebbe essere un segno di fidanzamento. E, in effetti, nel 1530 Neroni sposò la figlia di un ricco banchiere fiorentino. Gli storici dell’arte ipotizzano che le loro nozze potrebbero essere state il motivo della commissione del ritratto.
Giorgio Vasari, storico dell’arte e pittore rinascimentale, scrisse che dopo aver visto una delle prime opere del giovane Pontormo, Michelangelo osservò: «Questo giovane, a giudicare da quanto si vede qui, diventerà tale che, se vivrà e persevererà, esalterà quest’arte fino al cielo». Questi due magnifici ritratti di Pontormo esemplificano il talento del tutto personale dell’artista, e il fatto che entrambi siano stati probabilmente realizzati in un periodo di grande agitazione civile dimostra la capacità dell’arte di fiorire anche nelle circostanze più avverse.