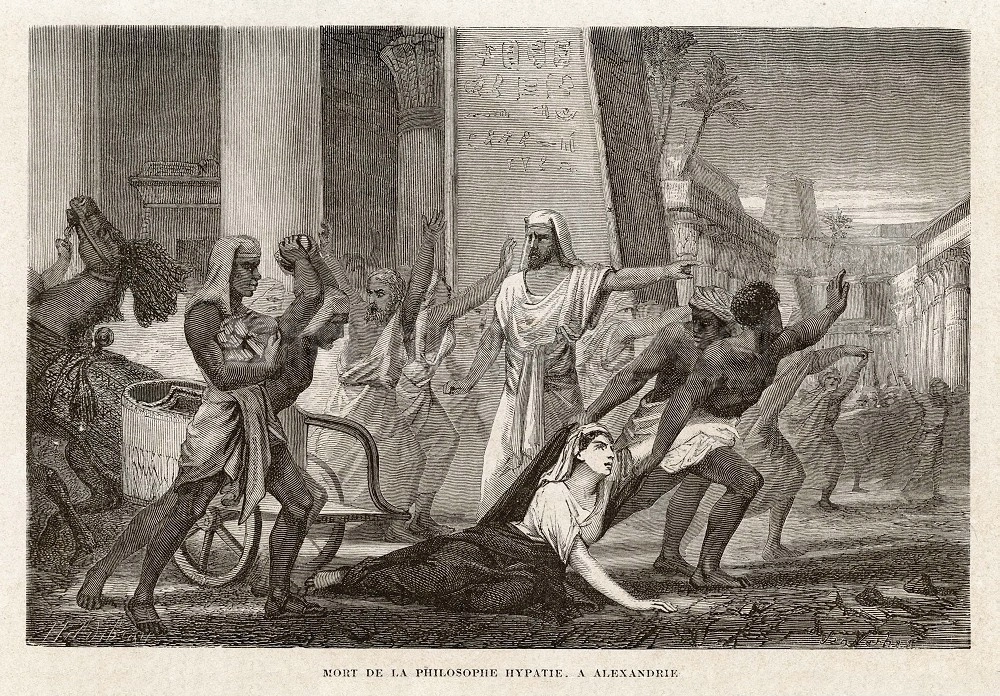Il tempo, per quanto sia considerato un dono prezioso, può essere a volte percepito come un distruttore implacabile. È facile dare valore a singoli momenti, ma qualcosa nello spirito umano si ribella alla sua stessa propria natura di creatura immersa nel tempo, alla natura mortale del corpo. La maggior parte delle persone teme lo scorrere e l’esaurirsi del tempo a disposizione e desidera sfuggire al suo dominio universale.
Considerando questa limitatezza, spesso può sembrare che non ci sia spazio per la bellezza, attributo che si può pensare non abbia una funzione immediatamente evidente. Inoltre, la bellezza spesso sembra non avere alcun valore pratico, ma è anche qualcosa che richiede tempo per essere prodotta e ancora più tempo per essere protetta.
La bellezza è fragile, il tempo la consuma facilmente. Un fiore germoglia e cresce lentamente, ma altrettanto velocemente appassisce o può venire calpestato. Un dipinto richiede un tempo immenso per essere realizzato e può essere perso o distrutto in un attimo. Di fronte all’inesorabile avanzare del tempo, allora, quale spazio occupa la bellezza?

William Shakespeare nel Sonetto 65, riflettendo sulla minaccia che il tempo rappresenta per la bellezza, si poneva la stessa domanda: anche le cose che appaiono più stabili al mondo, sono impotenti di fronte al tempo. Shakespeare medita quindi su come preservare il suo amore e la bellezza della persona amata.
Né la forza, rappresentata dall’ottone e dalla pietra, né la vastità, rappresentata dalla terra e dal mare, possono resistere al decadimento provocato dal tempo. C’è un dolore intrinseco nella mortalità: come suggerisce la furia inarrestabile che consuma tutte le cose, il tempo è una forza che non si ferma ad ascoltare la ragione o le argomentazioni della bellezza.
La bellezza sembra non avere difese, come suggerisce Shakespeare quando dice che non può «reggere l’urto dei giorni». Il tempo non ascolta alcuna argomentazione che possa sospendere la distruzione della bellezza.

Il tempo non si impegna in battaglie intellettuali e la bellezza non può impegnarsi nella guerra brutale che il tempo le muove contro, in un assedio devastante di giorni tormentati. La meditazione dolorosa della poesia è che il gioiello più prezioso del tempo stesso, l’amata di cui parla il poeta, sarà conservato nel “forziere del tempo” insieme a tutto il resto che il tempo ha rubato.
Nulla può fermare la mano del tempo, che saccheggia tutte le cose ma le rivendica anche come suo bottino. Proprio come il tempo è sia un dono che un saccheggiatore, le cose che rivendica sono viste sia come degradate che come bottino.
Allo stesso modo, c’è una dualità tra l’oscurità dell’inchiostro e la sua capacità di preservare la luminosità dell’amore del poeta: il “miracolo” della poesia, che interviene a dare eterna luce, è che le apparenti contraddizioni nella natura di queste cose (il tempo, l’inchiostro e la nostra stessa natura umana) possono coesistere.
In un certo senso, è insito in ognuna di queste cose un elemento di tristezza – il decadimento causato dal tempo, la nostra morte inevitabile e l’oscurità dell’inchiostro. Tuttavia, come l’oscurità dell’inchiostro può in qualche modo comunicare luminosità, e la bellezza può resistere nonostante la sua fragilità, il tempo stesso può avere ugualmente un potere illimitato ed essere limitato.
La bellezza, anche nelle sue forme più fugaci, ci offre uno sguardo su valori trascendenti, per questo la apprezziamo come qualcosa che sta quasi al di fuori del tempo. La cosa bella in sé è legata al tempo, ma rimanda a qualcosa di eterno che il decadimento del tempo non può toccare.

I versi del poeta si soffermano sull’idea ispirata dalla bellezza dell’amata: il pensiero che anche dopo che quella bellezza sarà svanita, la verità e la bontà trascendenti a cui essa rimanda rimarranno visibili nella parola scritta.
Si può sostenere che l’arte raggiunga il proprio scopo quando indirizza la mente in questa direzione. Il fatto che il nero inchiostro possa preservare lo splendore della giovinezza è un miracolo degno di contemplazione, poiché nonostante faccia qualcosa che sembra contrario alle sue proprietà naturali riesce a realizzare il fine che l’arte si propone.
L’uomo è consapevole della natura agrodolce del tempo ed è in grado di riconoscere sia la bontà della vita umana sia il dolore della propria mortalità. Per questo motivo, quando l’umanità gioisce di qualcosa di bello, spesso prova anche un senso di malinconia o una nostalgia quasi dolorosa.
Queste emozioni derivano dalla sensazione che l’uomo sia in attesa di qualcosa di più grande: una bellezza eterna da contemplare. Come dimostra Shakespeare, le aspirazioni umane e l’istinto artistico sono alla ricerca di questa bellezza eterna. Ci sforziamo di preservare la bellezza e l’amore che troviamo in questa vita affinché possano trascendere il tempo e la mortalità.
Attraverso la poesia, la bellezza, così delicata e facilmente perduta nel tempo, continua a risplendere con una luminosità intensa, immortalata nei versi.