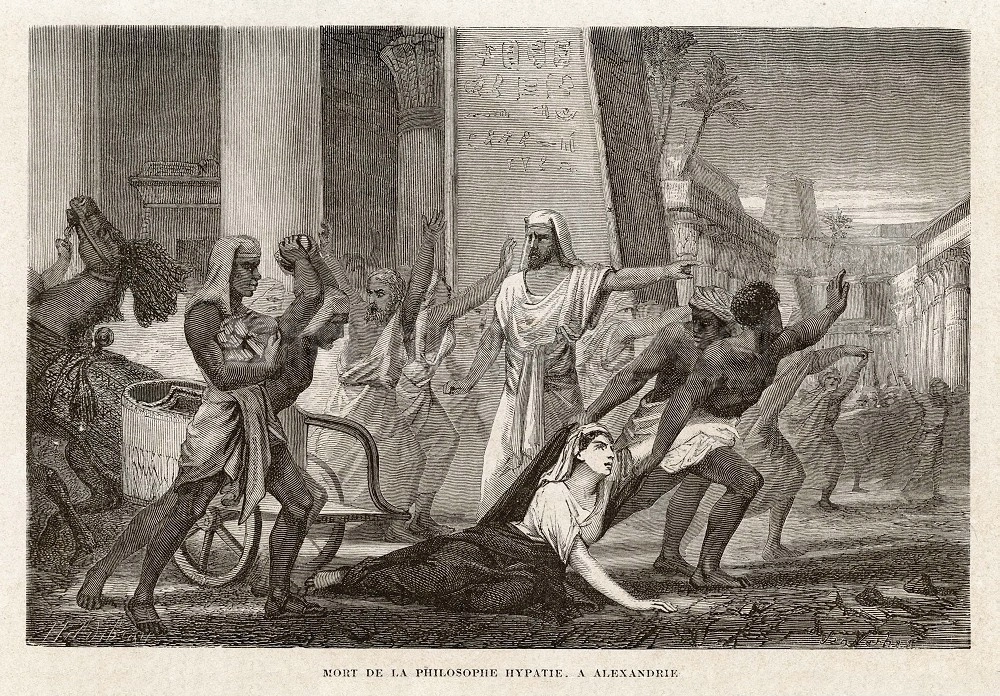Il poeta britannico William Wordsworth (1770-1850) non avrebbe saputo cosa fare con il ritmo frenetico della vita moderna. Nel 1807, in una poesia intitolata Il mondo è troppo con noi, deplorò l’invasione dell’industrializzazione in Inghilterra e la sua conseguente attenzione alla produttività e al guadagno.
Le persone stavano diventando cieche a tutto quanto stava al di fuori del mondo frenetico degli affari e del commercio, in particolare al mistero della generosa bellezza della natura. Sicuramente oggi la sua critica sarebbe ancora più forte, considerando che dal 1807 il ritmo della vita si è notevolmente accelerato e ancora meno persone si dedicano alla contemplazione del mondo naturale.

IL POETA DELLA NATURA
William Wordsworth fu una figura insolita e paradossale: per certi versi, sostenne il cambiamento e per altri versi lo rifiutò. Innovatore poetico e radicale in politica agli esordi, col passare del tempo divenne sempre più conservatore. Contribuì a dare inizio al rivoluzionario movimento romantico della poesia inglese, per poi essere ripudiato da molti dei giovani poeti che aveva ispirato, i quali sostenevano che avesse tradito la causa.
Il rammarico di Wordsworth per l’abbandono della bellezza a favore del profitto è un segnale del cambiamento di stile che riuscì ad avviare nella poesia. Come ha detto il professor Paul Brians della Washington State University: «Wordsworth cercò di rompere gli schemi di situazioni artificiose della poesia del XVIII secolo, che veniva scritta per le classi superiori, per arrivare a scrivere in un linguaggio semplice e diretto per l’uomo comune».
Piuttosto che ricorrere a situazioni fantastiche o insolite come soggetto della loro poesia, Wordsworth e i Romantici contemplavano il quotidiano, traendo la ricchezza poetica dalle cose comuni (soprattutto dal mondo naturale) e trovando lo straordinario nell’ordinario. Il mondo è troppo con noi enfatizza la magnificenza di elementi come il mare, il vento e i fiori – cose di tutti i giorni – che spesso ci sfuggono, preoccupati come siamo di «ottenere e spendere».
Wordsworth si oppose fermamente alla rivoluzione industriale che chiudeva le persone nelle fabbriche, e che proponeva come ideali primari l’efficienza e la produttività della società. Il poeta Andrew Spacey scrive che il sonetto di Wordsworth esprime la sua «accorata risposta alla scomparsa dell’industria artigianale e dello stile di vita rurale, che erano stati sostituiti dalla produzione di massa e dal lavoro in fabbrica. La gente non era più in contatto con la natura». Wordsworth attribuisce questo nuovo atteggiamento al «decadente cinismo materiale dell’epoca».

Pubblico dominio
Ecco il testo completo della poesia, che esprime questi sentimenti con linguaggio e immagini bellissimi:
The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers;
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon!
This Sea that bares her bosom to the moon;
The winds that will be howling at all hours,
And are up-gathered now like sleeping flowers;
For this, for everything, we are out of tune;
It moves us not. Great God! I’d rather be
A Pagan suckled in a creed outworn;
So might I, standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Proteus rising from the sea;
Or hear old Triton blow his wreathèd horn.
Il mondo è troppo con noi; tardi e presto,
Ottenendo e spendendo, devastiamo i nostri poteri;
Poco vediamo nella Natura che sia nostro;
Abbiamo dato via i nostri cuori, un sordido vantaggio!
Questo Mare che scopre il petto alla luna,
I venti che ululeranno a tutte le ore,
E ora si raccolgono come fiori addormentati,
Per questo, per tutto, siamo stonati;
Non ci commuove. Buon Dio! Preferirei essere
un pagano allattato in un credo logoro;
Così potrei io, in piedi su questa piacevole riva,
avere scorci che mi renderebbero meno desolato;
Osserva Proteo che sorge dal mare;
Oppure ascolta il vecchio Tritone suonare il suo corno a corona.
RIVIVERE IL SONETTO
Il componimento è un sonetto con uno schema di rime non convenzionale. In The Classic Hundred Poems, il professore William Harmon osserva che Wordsworth ha contribuito a rivitalizzare la forma poetica del sonetto dopo che era stata quasi esaurita da John Milton il secolo precedente. Wordsworth incorporò nei suoi sonetti sia sentimenti personali che messaggi politici.
Wordsworth inizia col distacco che si è creato tra l’umanità e la natura: Ottenendo e spendendo/ devastiamo i nostri poteri suona come un’accusa al mondo del commercio, suggerendo che l’anima umana è fatta per qualcosa di più di questo, che il suo potenziale è sprecato nell’obbrobrio dell’accumulo di profitti. Nel quarto verso Wordsworth utilizza l’espediente retorico dell’ecfonesi – un’esclamazione di emozione – per sottolineare la tragedia: Abbiamo dato via i nostri cuori, un sordido vantaggio!

Nei versi successivi, il poeta passa a una serie di brevi ma incantevoli immagini naturali, giustapponendole alle fatiche del mondo degli affari. Inizia col mare, che personifica, proprio come gli antichi greci che invoca alla fine della poesia. “Mare” è scritto in maiuscolo, come un nome proprio, gli vengono attribuite caratteristiche femminili (un seno) ed è anche in comunione con la luna. Questo spirito di comunione e personificazione del mondo naturale costituisce il punto centrale della visione della natura che Wordsworth difende.
Dall’acqua, Wordsworth passa all’aria, riferendosi ai venti che si raccolgono come fiori addormentati. La concezione di fiori addormentati è un’altra istanza di personificazione e allude al potere latente e nascosto della natura. L’uso di rime femminili (versi che terminano su sillabe non premute) come hours/flowers, in questi versi sottolinea la bellezza dolce e delicata del mondo naturale, che non si impone a chi non è disposto a guardare. Piuttosto, si mette a nudo per coloro che desiderano vedere. Ma Wordsworth dice che noi non vogliamo vederla: siamo stonati e non ci commuove.
Negli ultimi versi, Wordsworth si rivolge a chi si è lasciato commuovere dalla natura: gli antichi pagani, soprattutto i greci, per i quali la natura era misteriosa e viva, persino personale. Per loro, la natura non era un insieme di leggi passive o inerti del movimento o della biologia, ma una forza attiva animata da poteri invisibili, anche se occasionalmente intravisti.

Chi sta parlando di questa poesia ne farebbe quasi la propria fede religiosa poiché, se non altro, riconosce il mistero della natura, la sua energia e molteplicità inspiegabili, e vede in essa presenze superiori. Wordsworth fa riferimento a Proteo, il Vecchio del Mare della mitologia greca, che aveva il potere di assumere forme diverse e di pronunciare profezie, mentre Tritone era il figlio di Nettuno e poteva placare i mari con il suo corno a conchiglia.
Wordsworth pensava forse ai mari in tempesta che vedeva davanti a sé durante la rivoluzione industriale, e chiedeva un rinnovato apprezzamento della natura per placarla? Non possiamo saperlo, ma una cosa è certa: l’improvviso passaggio a una dimensione mitologica nella poesia è un finale potente, mentre l’immagine della testa di Tritone che irrompe dalla schiuma e accosta le labbra al corno per una lunga nota malinconica, che riecheggia sulle onde, è inquietante.
Per i Greci e nella poesia di Wordsworth c’è un paradosso: sebbene Proteo e Tritone non emergano letteralmente dal mare, allo stesso tempo, in un certo senso lo fanno, ma solo per chi ha occhi per vedere. Questo è il potere della poesia, che rende possibile l’impossibile e visibile l’invisibile, dando, come scrisse Shakespeare, «al nulla arioso una dimora locale e un nome».
Al meglio della loro espressività, sia la mitologia che la poesia portano alla luce l’essenza più profonda delle cose, come i mari o i venti. Abbiamo bisogno di poesie come quelle di Wordsworth per ricordarci il valore di queste cose, oggi più che mai, per evitare di dare via i nostri cuori alla macchina del commercio.