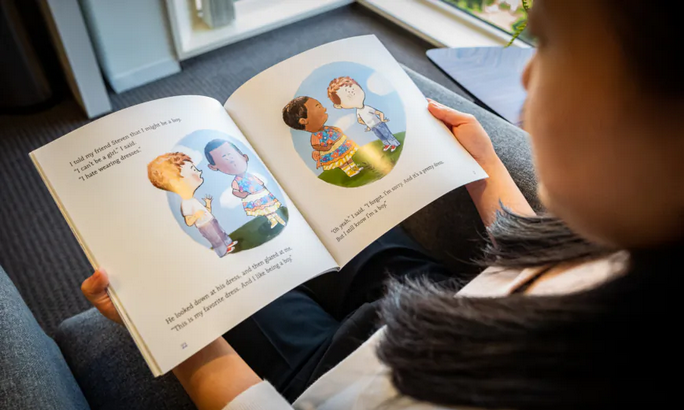Per anni, il legame tra vaccini e autismo è stato considerato definitivamente smentito. La comunità medica ha sostenuto con fermezza l’idea che la questione fosse chiusa e che le prove scientifiche fossero conclusive. Tuttavia, un’analisi indipendente condotta per il libro Between a Shot and a Hard Place ha restituito un quadro ben diverso. L’esame dei dati disponibili ha rivelato non un corpus robusto di ricerche, ma un numero limitato di studi, caratterizzati da ambiti ristretti e significative lacune metodologiche. Non si afferma che i vaccini causino autismo. Piuttosto, si evidenzia con urgenza che non esistono risposte definitive. Nessuno, al momento, può dichiarare con certezza che il nesso sia stato escluso in modo esaustivo. Ed è proprio questa incertezza a costituire il nucleo del problema.
L’autismo è una malattia neuro-evolutiva complessa, che può manifestarsi con sintomi lievi o con gravi compromissioni nel linguaggio, nelle abilità motorie e nell’autonomia. La sua prevalenza è in aumento. Secondo i dati più recenti, negli Stati Uniti 1 bambino su 31 riceve oggi una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. In California, il rapporto sale a 1 su 12,5. Se da un lato l’ampliamento dei criteri diagnostici e una maggiore consapevolezza spiegano parzialmente il fenomeno, non bastano a giustificare l’incremento dei casi più gravi. Attualmente, quasi due terzi dei bambini autistici presentano disabilità intellettive da moderate a profonde, una percentuale nettamente superiore rispetto al passato.
L’affermazione secondo cui la scienza avrebbe definitivamente escluso un legame tra vaccini e autismo si basa su una serie ristretta di studi, perlopiù focalizzati sul vaccino Mpr (morbillo, parotite, rosolia) e sul tiomersale, un conservante contenente mercurio eliminato da quasi tutti i vaccini oltre 20 anni fa. Le ricerche più frequentemente citate — tra cui Madsen (2002), DeStefano (2013) e Hviid (2019) — non confrontano bambini vaccinati con bambini non vaccinati, ma diverse tipologie di vaccinati. Un approccio che, in termini scientifici, equivarrebbe a studiare gli effetti del fumo confrontando solo le sigarette con e senza filtro ma ignorando i non fumatori.
Non esistono studi estesi che valutino l’intero calendario vaccinale proposto dal ministero della sanità americano in relazione all’autismo. Le ricerche citate nei testi dei principali esperti, come Peter Hotez o Paul Offit, ruotano attorno agli stessi dati su Mpr e tiomersale. Manca un esame sistematico di altri vaccini pediatrici — epatite B, Dtap, Hib, Ipv, Pcv, rotavirus, Rsv, influenza, vitamina K, epatite A, varicella — e delle loro combinazioni.
Non sono disponibili studi randomizzati a lungo termine che confrontino bambini completamente vaccinati e non vaccinati, né studi che valutino l’effetto cumulativo delle somministrazioni multiple. Gli adiuvanti a base di alluminio, noti per il loro potenziale infiammatorio nel sistema nervoso secondo studi su modelli animali, sono stati scarsamente indagati. Mancano analisi sui possibili effetti sinergici di dosi, tempistiche e ingredienti attivi del calendario vaccinale, così come dati a lungo termine sull’autismo legati a vaccini diversi dall’Mpr.
Nel 2013, un rapporto dell’Istituto di medicina — organo indipendente di consulenza del governo americano — ha riconosciuto che il calendario vaccinale dall’infanzia ai sei anni non è stato valutato in modo scientificamente esaustivo. Il documento ha rilevato l’assenza di prove sufficienti per confermare o escludere una correlazione con disturbi cerebrali o immunitari, compreso l’autismo. Una constatazione presente nella letteratura ufficiale, ma raramente trasmessa al pubblico.
Una revisione pubblicata su Pediatrics nel 2014, volta a sintetizzare la sicurezza dei vaccini pediatrici, cita l’autismo in nove occasioni, limitandosi a ribadire la non associazione con il vaccino Mpr. Tuttavia, menziona anche uno studio del 2010 di Gallagher e Goodman, secondo cui i bambini vaccinati contro l’epatite B nel primo mese di vita presentavano un rischio triplo di sviluppare autismo rispetto a quelli vaccinati più tardi o mai vaccinati. Un dato significativo, rimasto in gran parte inascoltato. Nel medesimo anno, William Thompson, scienziato del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha rivelato che uno studio del 2004, di cui era coautore, aveva omesso dati che indicavano un aumento del rischio di autismo nei bambini afroamericani vaccinati prima dei 36 mesi. Nessuna indagine pubblica è seguita alla sua denuncia, malgrado l’importanza delle informazioni rese note.
Numerosi genitori riferiscono esperienze simili: bambini che, dopo aver ricevuto uno o più vaccini, mostrano cambiamenti repentini nel comportamento, nella comunicazione e nell’interazione. Spesso, queste testimonianze vengono ignorate o liquidate come coincidenze. Eppure, la coerenza di questi episodi – in termini di sintomi e tempistiche – suggerisce la necessità di un’indagine indipendente. Non per confermare una causalità, ma per valutare se vi siano elementi degni di ulteriore approfondimento.
La scienza autentica non teme l’incertezza, ma la indaga. Occorrono studi longitudinali indipendenti che confrontino bambini vaccinati, parzialmente vaccinati e non vaccinati, con analisi di variabili interferenti e criteri diagnostici uniformi. Studi retrospettivi, che utilizzano database esistenti come il Vaccine Safety Datalink, potrebbero offrire risposte già oggi. In parallelo, studi prospettici osservazionali potrebbero coinvolgere famiglie che scelgono di rimandare o evitare le vaccinazioni, monitorando i bambini nel tempo. È necessario valutare non solo la presenza di un vaccino, ma anche le sue modalità di somministrazione, le combinazioni, la frequenza, l’effetto cumulativo degli ingredienti. Andrebbero esplorate anche possibili vulnerabilità genetiche o immunitarie che rendano alcuni bambini più suscettibili. Fondamentale, infine, è rimuovere i conflitti di interesse dalla ricerca sulla sicurezza vaccinale, garantendo piena trasparenza dei dati e trattando le osservazioni dei genitori come validi punti di partenza per lo studio scientifico.
Qui non si vuole esprimere nessuna posizione preconcetta contro i vaccini: la pratica clinica li utilizza per proteggere da malattie gravi. Ma l’integrità scientifica richiede apertura, onestà e rigore. Evitare lo studio di quello che non sia stato ancora approfondito, o bollare il dissenso come “complottismo” ormai serve solo a minare la fiducia nella medicina. Serve un dialogo aperto, che rispetti il consenso informato e accolga la complessità della realtà. Solo così sarà possibile garantire ai bambini la tutela che meritano.
Le informazioni e le opinioni contenute in questo articolo non costituiscono parere medico. Si consiglia di confrontarsi sul tema col proprio medico curante e/o con specialisti qualificati.