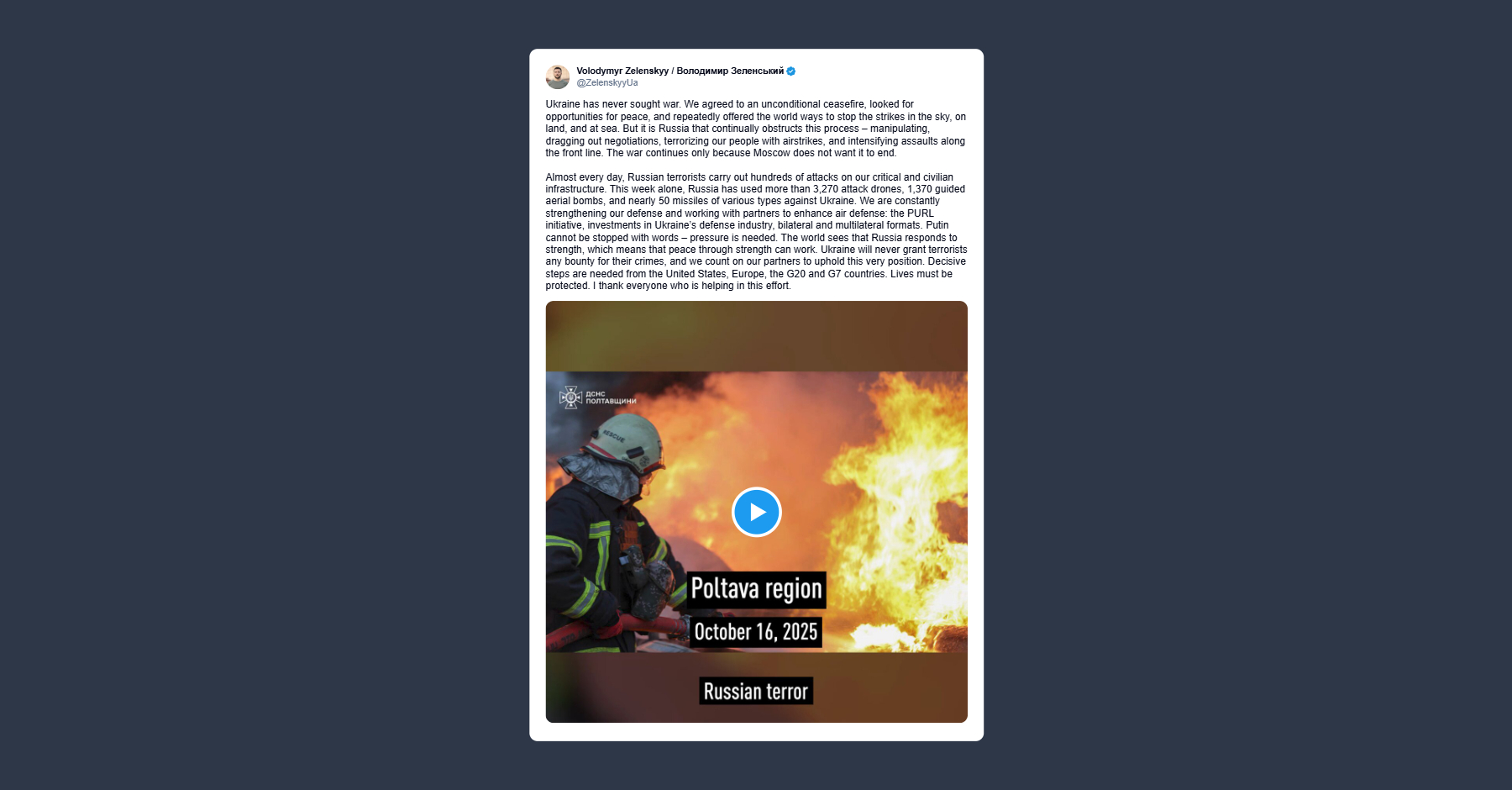Ogni governo del pianeta sta vacillando sotto i colpi tellurici della cosiddetta guerra dei dazi scatenata dal presidente degli Stati Uniti Trump. Eppure, molti sembrano non cogliere che la sua campagna per abolire i dazi a livello internazionale è una strategia per porre fine al dominio – e forse all’esistenza stessa – del Partito comunista cinese.
Nonostante il suo commento ironico sul grande amore per i dazi, Trump potrebbe passare alla Storia come il primo presidente americano davvero favorevole al libero scambio, liberando l’economia statunitense da protezionismi e dazi e rendendola più competitiva sul mercato internazionale, incentivando la produzione interna. Con le sue tattiche negoziali definite a colpo di granata, Trump ha avviato una strategia di contrattazione per ottenere l’eliminazione dei dazi imposti agli Stati Uniti, offrendo in cambio la rimozione reciproca delle barriere commerciali nei confronti dei Paesi che si adeguano.
Ma il regime cinese rappresenta un caso a parte. Il regime cinese si è messo in una posizione negoziale insostenibile: cedere alla richiesta di dazi zero dell’amministrazione Trump significherebbe perdere prestigio, e il Partito è oggi al suo punto più debole dal 1949. Trump sembra determinato a infliggergli un colpo mortale durante il suo mandato.
Gli alleati degli Stati Uniti, tuttavia, non colgono questa dinamica e continuano a dar credito alla retorica altisonante del Pcc. Di conseguenza, l’Occidente, in un momento cruciale di trasformazione dell’ordine internazionale, non riesce a esercitare una leadership efficace nel confronto con il regime cinese, ancora prigioniero dei miti sulla sua presunta forza.
Il modo in cui il Partito comunista cinese verrà gestito in questa fase determinerà la probabilità di un conflitto imminente – con Taiwan o in altri scenari – e definirà il quadro strategico futuro. La Cina di domani resterà il grande avversario dell’Occidente e degli Stati Uniti? O la Cina di oggi, percepita ora come un monolite invincibile, si frantumerà?
Il successo strategico si è sempre fondato sulla fiducia in sé stessi, autoconsapevolezza, determinazione e la capacità di valutare realisticamente le intenzioni e le risorse di alleati e avversari. Tuttavia, è altrettanto vero che individui e società, spesso, non comprendono a fondo né sé stessi né i propri alleati o nemici, mancando di un quadro realistico. Durante la Guerra Fredda, Unione Sovietica e Occidente si giudicavano a vicenda con vari gradi di cecità strategica. Oggi, l’Occidente – ammesso che esista ancora come entità coesa – non riesce a cogliere la vera natura del Pcc e viceversa.
Va detto, però, che il regime cinese dedica più energie a studiare l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, di quanto l’Occidente non faccia per comprendere il Pcc. I leader politici e militari occidentali tendono ad accettare acriticamente la sua propaganda al punto da chiamare il regime cinese semplicemente Cina, senza mai questionarne la legittimità come Stato-nazione o erede storico della Repubblica cinese o della Cina imperiale. Un errore simile fu commesso dagli Stati Uniti dopo la Prima guerra mondiale, quando identificavano l’Unione Sovietica con la Russia, o, dopo il crollo, quando consideravano la Russia post-sovietica come l’Unione Sovietica. Questo fraintendimento ha contribuito ai profondi conflitti euroasiatici di oggi.
Molti faticano a riconoscere i cambiamenti e preferiscono aggrapparsi a simboli e continuità storiche, un po’ come i generali accusati di combattere l’ultima guerra, non la prossima. Ne consegue che la realtà del regime non viene nemmeno riconosciuta dai leader occidentali, paralizzati dall’immagine di uno Stato cinese continentale onnipotente. I politici occidentali ignorano diverse realtà, in parte perché sollevare lo spettro di un avversario imminente e minaccioso serve a distogliere l’attenzione degli elettorati da altre questioni. Tuttavia, alcune tendenze sono ormai innegabili:
- Il leader del Pcc, Xi Jinping, è stato scavalcato dai suoi oppositori interni e sta perdendo progressivamente il controllo del potere. Questa situazione ha paralizzato il Partito e il Paese. La domanda, come sempre, è: chi gli succederà? Il processo è oggi sempre più incerto perché Xi ha cercato di eliminare ogni possibile rivale. Nel frattempo, l’intero apparato del Pcc è concentrato sulla propria sopravvivenza interna.
- L’economia del regime è in subbuglio, con un debito crescente, povertà e fame in aumento, un malcontento pubblico verso il Partito sempre più diffuso e risorse finanziarie quasi esaurite per sostenere le ambizioni internazionali, figuriamoci l’Iniziativa Belt and Road, simbolo del decennio passato di Xi. La Cina dipende ormai da forniture alimentari estere, e le sue risorse idriche sono inquinate. L’urbanizzazione accelerata e il successivo boom e il crollo del mercato immobiliare hanno disgregato la società.
- L’Esercito popolare di liberazione, che comprende tutte le forze armate del Pcc (ricordiamo che si tratta di un esercito del Partito, non nazionale), è fondamentalmente disfunzionale, privo di capacità belliche adeguate a causa di un comando e un controllo frammentato, tecnologie inaffidabili e fratture tra i vertici. Questo non significa che l’esercito non sia pericoloso, ma non è coeso nel sostegno a Xi, né favorevole a un conflitto con Taiwan o con altri Paesi limitrofi.
Tutto ciò accade mentre gran parte dell’Occidente è a sua volta in preda a disordini e paralisi sociali, distratta dalle lotte dei leader di vari Stati per mantenere il potere in un mondo in rapido cambiamento. Resta dunque la domanda: chi affronterà la Cina comunista? Forse nessuno. Chi saprà trarre vantaggio da un mondo nel caos? È forse questo l’obiettivo della nuova amministrazione Trump: abbandonare le alleanze fallimentari e i meccanismi di governance multinazionale per costruire una nuova, irresistibile potenza statunitense?