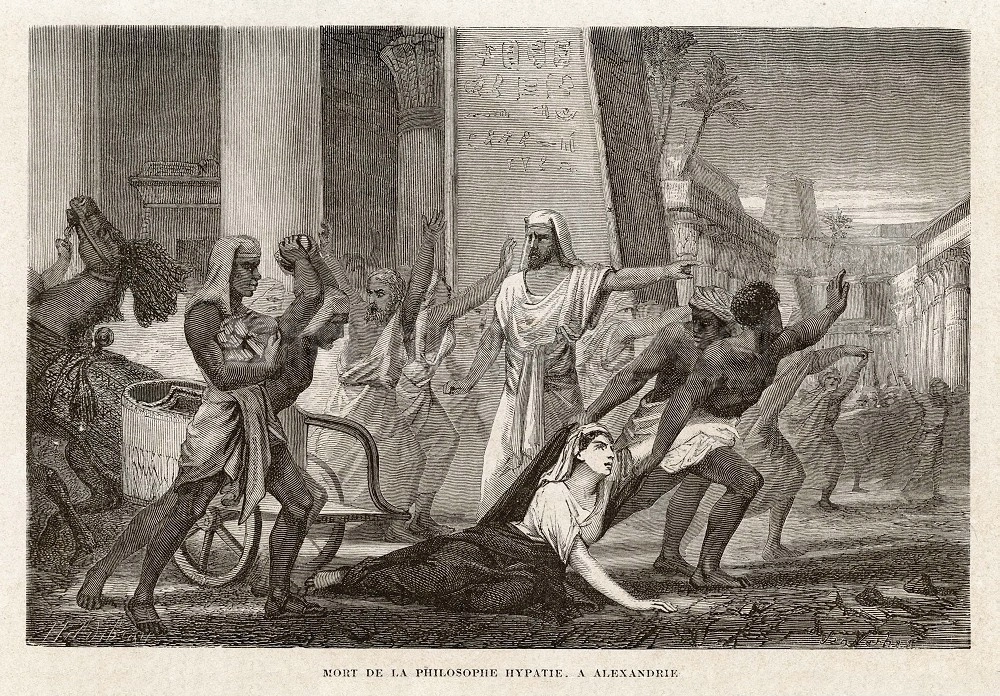Fin dall’inizio della storia umana, siamo stati affascinati dal fenomeno dei gemelli. Prendiamo alcuni esempi classici: Castore e Polluce (Gemelli della mitologia greca), Romolo e Remo (Romolo è il leggendario fondatore di Roma), Giacobbe ed Esaù (Giacobbe, che lottò con Dio e prese il nome di Israele) e Caino e Abele (figli di Adamo ed Eva). Sebbene Caino e Abele non siano indicati esplicitamente come gemelli, la tradizione vuole che lo fossero, e la loro relazione strettamente interconnessa implica fortemente una gemellarità. Ma perché questo fascino antico?
DOPPIA CURIOSITÀ
Una ragione si può riscontrare nella presenza di una dualità nella natura umana. Shakespeare, che ha esplorato la gemellarità in diverse opere, ha immortalato questa dualità in Amleto: «Che opera d’arte è l’uomo, com’è nobile nella sua ragione, infinito nelle sue facoltà! Nella forma e nel muoversi esatto e ammirevole, come somiglia a un angelo nell’agire, a un dio nell’intendere: la beltà del mondo, la perfezione tra gli animali – eppure, per me, cos’è questa quintessenza di polvere? L’uomo non ha incanto per me».
Questa dualità – la tensione tra il potenziale angelico e la fragilità della polvere – ci rimanda alla gemellarità. Simboleggia forze opposte ma intrecciate: in nessun altro luogo questa dualità è più evidente che nella sfera morale, regno della luce e delle tenebre, del giusto e dello sbagliato.
Nei testi antichi, la luce simboleggia la saggezza e la conoscenza. Apollo, dio greco del Sole, rappresenta la luce e la profezia, la capacità di illuminare l’oscurità del futuro; Artemide, dea della Luna e sua gemella diffonde la luce che attraversa le tenebre della notte. Apollo, che è tra i più venerati dei dell’Olimpo, punisce l’arroganza ovunque la trovi, sottolineando la dimensione morale della luce come verità e giustizia.

GEMELLI DELL’ANTICHITÀ
Tra i nostri esempi di gemelli, Castore e Polluce esemplificano un legame affettuoso e armonioso. Castore, mortale, e Polluce, immortale, erano gemelli non identici. Quando Castore fu ucciso in un conflitto, Polluce, sopraffatto dal dolore, supplicò Zeus di riunirli. Zeus offrì un compromesso: i fratelli si sarebbero alternati tra l’Olimpo e gli Inferi, condividendo l’immortalità di Polluce. Il loro legame eterno fu immortalato nella costellazione dei Gemelli. Questo mito sottolinea la dualità: il corpo (Castore) come mortale e l’anima (Polluce) come immortale. Il loro ricongiungimento allude alla resurrezione o alla trascendenza.

Romolo e Remo rappresentano un netto contrasto. Superate insieme le iniziali avversità (sono stati allattati da una lupa), in seguito litigano per la fondazione di Roma e Romolo uccide Remo, commettendo un fratricidio. A differenza di Castore e Polluce, essi rappresentano divisioni inconciliabili. Roma, che prende il nome da Romolo, diventa un simbolo di civiltà duratura, ma le sue fondamenta sono macchiate di sangue. Questa rottura permanente contrasta nettamente con la riconciliazione di Castore e Polluce.

Allo stesso modo, Caino e Abele incarnano forze opposte. Abele, a differenza di Remo, rimane significativo nella memoria religiosa e culturale. Cristo fa riferimento ad Abele, che compare anche nelle Epistole. Artisti e scrittori, tra cui Michelangelo, Rubens, Lord Byron e Gustave Doré, hanno immortalato Abele. Nella Sacra Bibbia, in Ebrei 11, Abele «sebbene morto, parla ancora», simboleggiando l’innocenza e la rettitudine.
La morte di Abele è rilevante anche per un altro motivo: segna il primo funerale registrato nella storia dell’umanità. La rappresentazione che Louis-Ernest Barrias propone di questo evento nella scultura Il primo funerale ne evidenzia la gravità. Abele è il primo essere umano a morire, la prima vittima di un omicidio e la prima a subire un fratricidio. I suoi genitori, Adamo ed Eva, piangono il figlio in quello che può essere visto come il primo confronto dell’umanità con la mortalità – un funerale – e con le conseguenze del peccato.

Questo funerale indica una frattura profonda nello spirito umano: nato per l’immortalità ma ora destinato a morire; le due facce della nostra natura. Prima di uccidere il suo gemello Caino ha peccato e Dio lo ha avvertito del pericolo che correva. Ma qual era il peccato «accovacciato alla porta» di cui si parla nella Genesi? Era il suo sacrificio che fu rifiutato da Dio. Perché? Dopo la Caduta di Adamo ed Eva Dio li coprì con pelli di animali: il sacrificio, cioè, comportava la morte degli animali e lo «spargimento di sangue».
Il sacrificio è alla base di tutte le religioni, ma Caino non lo capì o non volle capirlo. Invece, continuò a fare il lavoro di contadino, a coltivare i frutti, a lavorare la terra, come aveva fatto suo padre prima della Caduta. Caino si comportava come se la caduta non ci fosse stata. Cioè, il dono non poteva essere accettato da Dio non per quello che era in sé, ma per quello che rivelava dello spirito di chi lo offriva: non era un vero sacrificio a Dio. Commise il peccato di negazione, la negazione della realtà.
Caino, come Romolo, divenne un costruttore di città, un progenitore della civiltà. La civiltà spesso nasce dallo spargimento di sangue e dall’ingiustizia. La Bibbia non descrive con precisione la fine di Caino, ma nell’antico apocrifo ebraico Libro dei Giubilei si può leggere una risoluzione morale adeguata: Caino, che ha ucciso Abele con una pietra, muore quando la casa di pietre, che lui stesso aveva costruito, gli crolla addosso. Questa giustizia metaforica richiama il concetto del “contrappasso” (come in Dante), dove la punizione corrisponde al peccato.

I gemelli ci affascinano perché sono il simbolo della nostra dualità interiore. Castore e Polluce rappresentano la speranza attraverso l’unità e la trascendenza; ma Romolo e Remo, e Caino e Abele, ci ricordano la divisione e le sue conseguenze. Queste storie rispecchiano la condizione umana, per questo suscitano in noi un’eco particolare: il nostro potenziale di amore, sacrificio e riconciliazione, ma anche la nostra propensione all’orgoglio, alla negazione e alla violenza. Riflettendo su queste storie, intravediamo verità su noi stessi e sul mondo. Forse è per questo che, come suggerisce l’eredità di Abele, anche nella morte questi archetipi continuano a parlare.